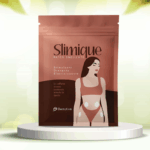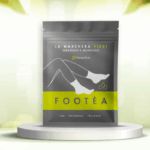Spesso nel parlare comune si assiste a esitazioni, errori o incertezze nell’uso del femminile di molti nomi professionali, in particolare per quei termini che storicamente sono stati declinati quasi esclusivamente al maschile. Il termine che individua chi cura e mantiene i giardini è uno di questi casi emblematici, e la domanda su quale sia effettivamente la forma corretta al femminile continua a generare dubbi in molti parlanti.
La grammatica italiana dei nomi di mestiere
La grammatica italiana, nelle sue regole fondamentali, prevede che molti nomi di persona siano mobili, cioè abbiano una forma distinta per il maschile e il femminile. Si tratta di una caratteristica che facilita la corretta designazione del genere di chi esercita una determinata professione. Il giardiniere, dal punto di vista morfologico, fa parte di questa categoria: la parola nasce dall’unione del sostantivo “giardino” e del suffisso agentivo in -iere, secondo un meccanismo analogo a quello di altri nomi come “cameriere”, “ingegnere”, “cuoco” (grammatica italiana).
I cosiddetti nomi mobili modificano la loro desinenza quando cambiano genere: in genere la –e finale viene sostituita da una –a per la forma femminile. È questa la modalità di formazione più naturale e logica in italiano, secondo le regole che presiedono la declinazione dei nomi di mestiere. Un’analisi grammaticale dettagliata conferma la presenza di questa mobilità in termini come “giardiniere/giardiniera”, “direttore/direttrice”, “prigioniero/prigioniera” e molti altri.
Qual è la forma corretta del femminile
Nonostante permangano dubbi tra i parlanti, la risposta è netta: la forma femminile del sostantivo “giardiniere” è giardiniera. A differenza di altri mestieri che, a seconda della tradizione e dello sviluppo della lingua, possono mantenere una forma invariata al femminile (ad esempio “il/la cantante”), il termine relativo a chi cura i giardini si conforma regolarmente alle norme della lingua italiana e prevede la variante giardiniera per il genere femminile. Questa trasformazione segue lo stesso modello di cambiamento già osservato per altre parole con la medesima struttura morfo-sintattica.
Gli strumenti normativi della lingua, dai dizionari storici alle grammatiche ad uso scolastico, confermano senza esitazione tale regola. In effetti, la parola “giardiniera” non è solo attestata come corretta dal punto di vista della formazione grammaticale, ma è anche riportata da tutte le principali fonti lessicografiche contemporanee, compresi Garzanti, Treccani, Hoepli e dizionari digitali come Wiktionary. Riconoscere e utilizzare correttamente questa parola significa sia rispettare la lingua sia valorizzare la presenza delle donne nelle professioni storicamente maschili.
Motivi degli errori e falsi miti
Il principale motivo che porta molti a sbagliare è duplice:
- Confusione dovuta al fatto che il termine “giardiniera” identifica anche una celebre specialità gastronomica (un antipasto di verdure sott’aceto molto diffuso), il che può indurre erroneamente a credere che si tratti di una parola a sé e che, pertanto, non sia corretto utilizzarla come femminile di “giardiniere”.
- Percezione che il suffisso agentivo in -iere non sempre trovi una controparte femminile regolare oppure scarsa abitudine all’uso di parole professionali declinate al femminile, in una lingua che solo di recente sta recuperando la parità linguistica nei mestieri.
In realtà, la duplicazione di significato è pienamente accettata dal sistema lessicale italiano, che spesso contempla omonimie e polisemia. La coincidenza tra il termine che designa un mestiere e quello che identifica una ricetta non costituisce un errore, ma una semplice peculiarità semantica. Analoghe situazioni si riscontrano in altri nomi della lingua italiana. L’articolo correttamente usato — “la giardiniera” se si parla di una donna che cura i giardini — elimina ogni possibile ambiguità dal contesto.
La centralità di una lingua inclusiva e le attuali indicazioni
Nella società contemporanea si discute sempre più spesso dell’importanza dell’uso di un linguaggio inclusivo e rispettoso delle identità. La tendenza delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche e dei media è di adottare sistematicamente i femminili professionali sia per ragioni di correttezza grammaticale che di principi di pari opportunità. Utilizzare giardiniera per indicare una donna che esercita la professione di cura dei giardini significa non solo allinearsi alle norme linguistiche, ma anche a quelle civili-sociali emerse negli ultimi decenni.
Anche i documenti stilistici ufficiali e le linee guida di molti centri di ricerca raccomandano l’utilizzo del femminile regolare nei nomi di mestiere e ruoli pubblici, con l’obiettivo di:
- Favorire la visibilità delle donne in ogni ambito professionale
- Neutralizzare gli automatismi linguistici che rinforzano stereotipi di esclusività maschile
- Assicurare coerenza tra la realtà del mondo del lavoro e la sua rappresentazione nella lingua
Inoltre, la corretta declinazione delle parole, inclusa “giardiniera”, viene ormai insegnata sin dalla scuola primaria nello studio della grammatica e nei percorsi di educazione civica, con esercizi espliciti orientati a distinguere tra il genere dei nomi e il corretto impiego degli articoli associati.
Da qui si comprende come la consapevolezza e il rispetto per la correttezza linguistica non siano elementi marginali, ma parte integrante di una società che mira all’uguaglianza e alla precisione comunicativa.
La questione della forma femminile di “giardiniere” non si risolve quindi in una mera regola formale, ma richiama una più ampia riflessione sull’evoluzione della lingua, l’inclusività e il ruolo che il lessico ha nel rappresentare la società attuale.